Nel 1983 usciva per Ares Il cavallo rosso, un romanzo destinato a successo che dura tuttora: Cavalleri accettò il lavoro di Corti, definendolo da subito «il Guerra e Pace italiano». Ripresentiamo il primo intervento sul romanzo di Corti che Cavalleri scrisse su Sc 270-271 (agosto-settembre 1983).
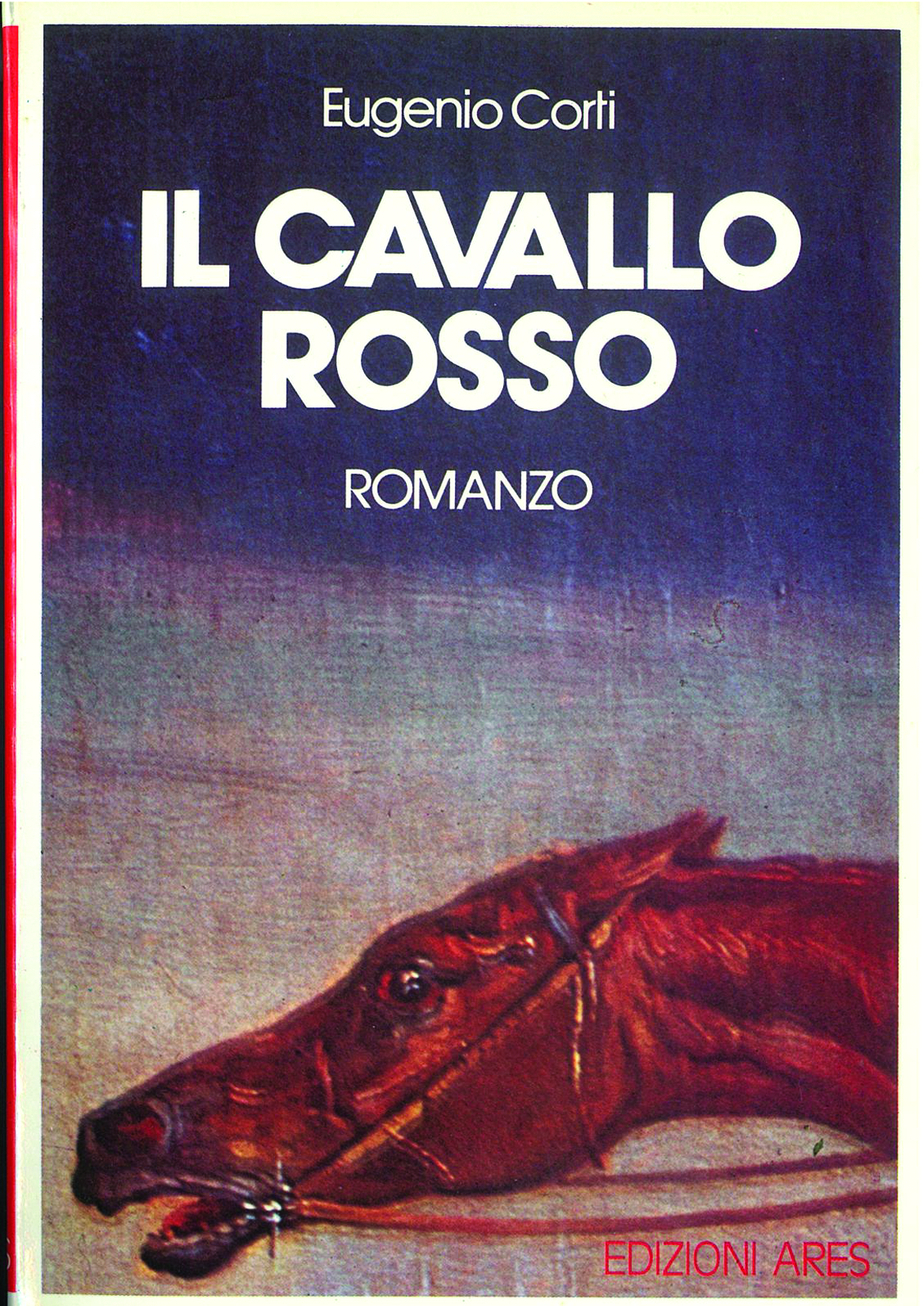
«Il ventenne Moioli, bergamasco, puntatore del primo pezzo, era tra quelli che delle donne parlavano con fiducia. “Che bella cosa l’amore!” concludeva a volte le sue svagatezze, con molta ingenuità. Un giorno Ambrogio, ch’era in visita appunto nella tenda del primo pezzo, gli chiese: “Ma di’ un po’: tu l’amore l’hai mai provato?”. Moioli lì per lì rimase imbarazzato. “Signornò” rispose infine “se devo essere sincero”. A costo di fare cattiva figura davanti ai suoi compagni non era disposto a mentire, bergamasco e onesto com’era. Aveva da poco compiuto vent’anni. (È concesso allo scrittore di salutarti, Moioli? Saresti presto morto, come molti degli altri. La tua figura di bravo ragazzo riaffiora qui solo per qualche istante prima d’essere nuovamente inghiottita dal tempo, che tutto afferra e trascina via)» (p. 185). Così, con questa immediatezza, con il coraggioso pudore della verità, con il realistico ancoraggio alla storicità degli eventi, dei luoghi, dei nomi, e con la capacità trasfiguratrice dei grandi narratori, Eugenio Corti ha scritto un romanzo di 1.280 pagine, Il cavallo rosso (Edizioni Ares, Milano 1983, L. 24.000), che avrà un posto a sé nella letteratura dei nostri anni.
Un romanzo che ha il respiro di Guerra e pace, l’inoppugnabilità del miglior Solženicyn, la tenerezza ctonia del cinematografico Albero degli zoccoli. Ma perché fare paragoni? Siamo di fronte a un’opera originale e unica, che contiene in sé anche i parametri della valutazione estetica.
Il cavallo rosso conferma che la grande arte viene sempre dal lavoro solitario. Eugenio Corti, ben noto ai lettori di Sc anche come sovietologo, ha al suo attivo un romanzo di grande successo, I più non ritornano (otto edizioni Garzanti, dal 1947 al 1973), che ha avuto riconoscimenti da Benedetto Croce, da Mario Apollonio e da altri luminari; ha scritto ancora I poveri cristi, ha rappresentato la tragedia Processo e morte di Stalin, e ha pubblicato altre opere saggistiche e narrative; ma è rimasto volutamente fuori dal milieu letterario, dal chiacchiericcio salottiero in cui tante belle intelligenze sono state dilapidate, ed è sempre rimasto fedele al suo mondo, alle esperienze di prima mano, favorite dal relativo isolamento della sua bella casa in Brianza.
Un’opera colossale
Per scrivere Il cavallo rosso ha impiegato undici anni. Non ne occorrevano di meno per consegnarci un’opera di questa mole e di questa perfezione, in cui il background documentario non appesantisce in nulla la scrittura, perché questo è un romanzo di idee ma incarnate in personaggi, avvenimenti; è letteratura autentica, non pretesto per considerazioni ideologiche o comunque saggistiche. Sono 1.280 pagine nessuna delle quali è superflua, scandite in brevi sequenze quasi di taglio cinematografico che ne rendono agevole e avvincente la lettura, senza una caduta, senza un cedimento.
La tragedia della nostra epoca, in cui il nazismo e il comunismo esprimono vistosamente la presenza del male nella storia, è tematizzata e analizzata attraverso le vicende, in pace e in guerra, di alcuni giovani briantei, nell’arco di tempo che va dal 1940 al 1974. Lo sfondo culturale è quello della Brianza di quarant’anni fa, intrisa di cattolicesimo, di imprenditorialità e di splendide virtù morali innervate da un acuto senso del dovere. Una Brianza “paolotta” che oggi appare remota ma che è stata ben viva e forse lo è ancora, nonostante le apparenze del permissivismo e del “progresso”, e della quale, comunque, era giusto consegnare intatto il ricordo alle generazioni venture.
Il romanzo è scandito in tre parti, intitolate Il cavallo rosso (che dà il titolo all’intero volume), Il cavallo livido (entrambi i simboli sono dell’Apocalisse) e L’albero della vita. Ma la narrazione procede secondo due movimenti: dapprima è ascendente, e culmina negli eventi del 1948, poi si ripiega e digrada. È l’onda della storia che sale imponente e si colma d’epiche speranze, poi s’increspa e cade nello sciabordìo della risacca.
Per Ambrogio, Manno, Michele, Luca, Stefano, Pierello, ragazzi di Nomana e delle frazioni vicine, cresciuti insieme completamente immemori delle differenze sociali, la guerra è, all’inizio, come un grande gioco, un’avventura. È il contatto con un mondo nuovo, diverso, in cui il rischio della vita è un’eventualità dubbiosa e non temuta. Come i loro commilitoni, questi giovani hanno «con la comunità organizzata, diciamo con lo Stato, un rapporto analogo a quello che si ha con la natura: dentro la quale si nasce, e che con una certa periodicità ci sottopone purtroppo a cataclismi cui bisogna per forza di cose far fronte. C’è chi li affronta con più, e chi con minor coraggio, o decenza, o anche con indecenza, chi – specie se è cristiano – con maggiore, e chi con minor altruismo, e molti senza alcun altruismo».
Il dramma della guerra
Manno è destinato al fronte libico, gli altri, presto o tardi, finiscono in Russia. Nei primi tempi riescono addirittura a mantenere i contatti fra loro, si scambiano visite, la posta dall’Italia in qualche modo funziona, l’esperienza si arricchisce di nuovi personaggi (nessuno dei quali è “minore”) con i quali anche il lettore entra in simpatia. Ma ben presto la commedia di una guerra nella quale la gioventù italiana è stata gettata allo sbaraglio, precipita in dramma. Il fronte russo è travolto e lo sfaldarsi dell’esercito è visto, soprattutto da Ambrogio e da Michele, come immagine speculare della mancanza di coesione e di virtù civili in tempo di pace. Stefano sarà il primo a uscire di scena, combattendo da valoroso bersagliere. Ambrogio è ferito e si salva grazie all’abnegazione del suo attendente, l’umbro Paccoi. Michele, che tanto aveva desiderato di conoscere da vicino il mondo comunista per alimentare la sua vocazione di scrittore, è fatto prigioniero.
L’epopea di Manno si svolge su un diverso scenario. Anche in Africa l’esercito italiano è polverizzato nei primi scontri col nemico, e Manno, per non cadere prigioniero, riesce fortunosamente a raggiungere la Sicilia con una barca a motore. Egli si sente invulnerabile, come protetto da una predestinazione divina che lo riserva per grandi imprese di ardimento e di servizio. E poi, durante una licenza, ha conosciuto Colomba, una splendida ragazza con la quale ha deciso di costruire la sua vita. Di nuovo in Italia, Manno si mette a disposizione dei superiori e viene spedito in Grecia, dove è sorpreso dall’armistizio. Trova nell’eroico colonnello Cirino un modello ideale, ma il suo posto è altrove. Sarà tra i primi ad arruolarsi nei rinforzi alla quinta armata americana, e troverà la morte (medaglia d’oro) nella battaglia di Montelungo. E lì, negli estremi istanti, capirà il senso della missione alla quale la Provvidenza l’aveva riservato: sacrificare la sua giovane vita per «collaborare all’inizio della risalita, al recupero dell’Italia dalla palude».
La provincia salva l’Italia
In effetti, il Paese rinato alla democrazia incomincia ad assumere una fisionomia nuova per merito di chi, come il padre di Ambrogio, l’industriale Gerardo Riva, si prodiga per creare nuovi posti di lavoro, e di chi, come Luca, come Pierello, riprende il suo posto con energia. La vittoria politica del 1948 è il sigillo di una grande speranza. Ma già i segni della corrosione si fanno sentire. C’è come un’enorme riserva di energie che, a poco a poco, viene esautorata. Anche l’esperienza della guerra, in cui i giovani avevano appreso la responsabilità di decisioni dalle quali dipendevano la propria vita e quella di altri, si allontana, appare intraducibile, come avviene per Pierello, l’onesto, mite Pierello che, nella sua semplicità di popolano, non trova nemmeno le parole per raccontare che cosa gli è capitato durante la tremenda evacuazione della Prussia, sotto l’incalzare del tallone sovietico: «Più volte ci s’era provato: ma si era accorto che di queste cose poteva parlare con costrutto solo con chi era passato per esperienze analoghe. Gli altri non riescono a capirti, a rendersi con chiarezza conto dei fatti che tu riferisci. Questo non soltanto in treno o in fabbrica, ma dovunque, anche al tuo paese, perfino in casa, dove tua madre – pur agitandosi tutta, poveretta – finisce solo col provare una gran pietà per te e per gli altri che ci si son trovati… Così l’enorme esperienza ch’egli aveva messa insieme, e alla quale ritornava a volte col pensiero, tutte queste cose egli era costretto a tenersele soltanto per sé» (pp. 970-71).
Ambrogio, che si è laureato in economia, riprende a collaborare nell’azienda paterna che, dopo il fallimento dell’unione doganale europea, conosce gravi dissesti. Ambrogio ha sposato Fanny, la collega d’università che lo aveva assistito come crocerossina durante la lunghissima convalescenza nell’ospedale di Stresa. È un matrimonio di devozione, più che d’amore, dopo che Ambrogio non aveva osato dichiararsi a Colomba, essendo innamorati l’uno dell’altra, per rispetto alla memoria di Manno. Ambrogio rivedrà Colomba verso la fine del romanzo, vedova piena di rimpianti e, ancora una volta, la fedeltà verso la moglie, che pure per diversità di formazione sente sempre più lontana, avrà la meglio sull’impulso di realizzare tardivamente il sogno di un’irripetibile giovinezza.
Michele, nel quale i riferimenti autobiografici sono più scoperti, scriverà il suo libro sull’esperienza russa, ma, dopo questo primo successo, verrà gradualmente emarginato dall’establishment culturale. Il suo indomito impegno, però, non conosce soste e trova applicazione nella campagna per il referendum sul divorzio, nel 1974. E proprio per venirgli incontro, in una notte in cui Michele era rimasto lontano da casa per un banale guasto d’automobile, sua moglie Alma, l’unico amore della sua vita, la cui immagine di adolescente incantata gli aveva consentito di superare le atrocità dei lager sovietici, trova la morte in un incidente provocato dallo sbandamento di un’auto guidata da un giovane drogato.
Su questa morte si chiude il romanzo che, in un certo senso, è un’epopea di perdenti, perché anche la verità può conoscere eclissi e sconfitte, pur restando intatta e vera.
La morte di Alma non è un espediente letterario. È la condizione necessaria per una successiva rigenerazione civile. Così come la morte di Manno era stata il sotterraneo fermento della riscossa nazionale, allo stesso modo il sacrificio di Alma, cioè l’olocausto di una famiglia felice benché non allietata dalla nascita di figli, è pegno di riscatto. La famiglia, infatti, è il valore intorno al quale si coagula la coesione sociale che, per attuarsi, sembra suggerire Corti, ha misteriosamente bisogno di màrtiri. La speranza, nonostante i risultati del referendum alla vigilia del quale il romanzo ha termine, è simboleggiata dalla serietà dei due figli di Ambrogio, moralmente così sani, così degni dei Riva e dei nomanesi che hanno scritto pagine di storia di cui loro stessi sono ignari. L’affacciarsi di questa nuova generazione è il definitivo segno di speranza che il romanzo ci consegna.
Ci rendiamo conto che l’aver riassunto per linee tematico-esistenziali la trama del romanzo, incentrandolo sulle vicende di alcuni protagonisti, rischia fortemente di darne un’immagine impoverita e riduttiva. Infatti, nel Cavallo rosso c’è ben altro, e anche noi ci troviamo nella condizione di Pierello: dopo questa esperienza di lettura, ci mancano le parole. E tuttavia, nel romanzo di Corti, storia, scrittura e personaggi sono così intimamente intrecciati che è impossibile parlarne in astratto, occorre affrontare i contenuti, la trama.
Ricapitoliamo, per dare un’idea dell’incompletezza della nostra ricostruzione, alcuni degli aspetti che meriterebbero una trattazione specifica e diffusa. Del resto, questo libro offre materia per innumerevoli tesi di laurea. (Passando dalla prima persona plurale alla prima singolare, mi sento in dovere di informare che non avverto nessun imbarazzo nella duplice veste di editore e di recensore del romanzo di Corti. Per chiunque sappia minimamente come vanno le cose nel mondo editoriale, un semplice rapporto tra il prezzo del volume e il numero delle pagine è sufficiente e escludere ogni interesse di cassetta. Dunque il mio entusiasmo di recensore è al di sopra di ogni sospetto. Altro è il discorso sul perché un romanzo come questo venga pubblicato dall’Ares, che non ha una collana di narrativa – ma questo libro è un invidiabile inizio –, anziché da un “grande” editore specializzato. Una prima ragione è che i costi industriali dei grandi editori renderebbero proibitivo per il pubblico un romanzo di 1.280 pagine; una seconda è che, con ogni evidenza, un libro come questo scandalizza le ideologie dominanti. Dunque, tanto peggio per i grandi editori).
La condanna dei totalitarismi
Comunismo e nazismo sono ricondotti alla radice della loro perversione: il loro sostanziale ateismo, con il conseguente rifiuto dell’evidenza del peccato originale. I tremendi risultati del tentativo comunista di costruire un’umanità nuova sono visti, con gli occhi di Michele, nella loro spaventosa atrocità: deportazioni in massa, genocidio, miseria materiale, imbestiamento dell’uomo. La condanna del nazismo è accentuata da una sorta di rimpianto: per Corti, infatti, il nostro poteva essere il secolo dei tedeschi, in quanto quel popolo aveva i titoli per dare un apporto specifico di civiltà, come avvenne per gli elleni nei tempi antichi, poi per i romani, per gli italiani nel Medioevo, per gli spagnoli nel Cinquecento, i francesi nel Settecento, gli inglesi nell’Ottocento. Invece il nazismo ha sprecato tutto, anche per l’innestarsi di meccanismi autopunitivi, come l’espediente elaborato da Speer-Rathenauper aumentare la produzione bellica, sottilmente rilevato da Corti (p. 807).
Il fascismo è visto come fenomeno del tutto estraneo alla popolazione, almeno a quella briantea. Bastano le pagine sull’adunata nella piazza di Nomana dove la gente confluisce per ascoltare alla radio l’annuncio di Mussolini dell’entrata in guerra (pp. 44 ss.), per far capire come la tragica farsa del fascismo fosse avvertita come tale, eppure senza scapito delle virtù civile che, fra l’altro, inducono a servire generosamente una patria così malamente rappresentata.
La religiosità
Il cavallo rosso è un romanzo cristiano non perché parli di fede, ma perché riporta comportamenti pienamente cristiani. Il cristianesimo non è, nel libro, una sorta di ideale a cui tendere, ma, sia pure con la consapevolezza delle limitazioni umane, è da incarnare, è già incarnato fin da ora. E soltanto il rapporto con Dio, mediato dalla Chiesa, può assicurare il fondamento della pace sociale e della concordia tra le nazioni.
Questa visione profondamente e audacemente cristiana consente a Corti di istituire con i suoi personaggi un rapporto di pietas per cui, se netta è la separazione tra il bene e il male, incerta è la demarcazione tra buoni e cattivi. Fra i “cattivi” vengono sempre identificati anche dei “buoni”, e non si manca di denunciare, tra i “buoni”, chi tradisce la coerenza.
Un aspetto particolare di questa visione integralmente cristiana è la trattazione della vita affettiva dei personaggi. Corti descrive un mondo in cui gran parte dei ragazzi, per non parlare delle ragazze, giungeva vergine al matrimonio. E questi ragazzi, sanissimi e molto virili, hanno un modo di interessarsi alle ragazze e di innamorarsi, teneramente goffo e capace di slanci assoluti, che fa scandalo nei nostri tempi di dilagante permissivismo, dando la misura di quanto si perde, proprio in termini umani, nello sciupare l’amore in esperienze avvilenti. Sarà Alma (p. 1.038) a esprimere la consapevolezza che lo splendore totale del suo amore per Michele era anche dovuto, in non piccola parte, al fatto di essersi sempre attenuta alle norme della morale cristiana. È una bella sfida, che farà aprire gli occhi a molti giovani lettori.
La storia
Pur nel travestimento romanzesco, Corti non lesina le informazioni storiche e i giudizi sulla storia. Tutti gli episodi bellici, nei diversi fronti in cui i personaggi vengono a trovarsi, sono rigorosamente documentati, e riportati con attendibile minuziosità.
Largo spazio è dedicato anche alla lotta partigiana, drasticamente spogliata dell’epicità posticcia che le è stata attribuita. Non a caso, Corti assegna il ruolo di partigiano a Pino, il più fragile dei ragazzi Riva, che parteciperà alla vicenda della Repubblica dell’Ossola più per sperimentare sé stesso, per fatuità, che non per reali convinzioni ideali (più tardi, però, Pino diventerà medico missionario). Addirittura, sferzante Corti è con gli intellettuali utopisti che, in veste di commissari governativi, contribuirono al fallimento dell’esperimento ossolano con le loro interminabili discussioni teoriche, pronti poi a rifugiarsi in Svizzera ai primi segni di pericolo. Corti attribuisce inoltre alle formazioni partigiane cattoliche dei fratelli Alfredo e Antonio Di Dio tutto il merito che è loro dovuto, con severo ridimensionamento dell’apporto comunista.
Inoltre le vicende dei Comitati di Liberazione Nazionale, proiettate nel microcosmo di Nomana, acquistano un valore storico più vicino alla realtà che non alla mitologia successiva.
Anche avvenimenti recenti, come la campagna referendaria del 1974 e la contestazione giovanile (che Pierello patisce attraverso il figlio sessantottardo, purtroppo sobillato da un prete indegno dell’abito che perdipiù ha smesso di portare), sono valutate con rigore e secondo verità.
L’apporto storiografico di Corti è tanto più importante in quanto dissoda zone solitamente poco frequentate, e legge gli avvenimenti secondo un’ottica scandalosamente inconsueta: cristiana, appunto.
La letteratura
A un’analisi strettamente letteraria, il romanzo rivela una tenuta più unica che rara. Ogni pagina è ritmicamente calibrata, le sequenze sono montate con perfetta scansione, i toni del dramma, della lirica, della tragedia, e anche dell’umorismo, si alternano rinsaldando un’unità stilistica in cui la semplicità è il punto d’arrivo d’una ricerca che percorre il molteplice senza lasciarsi catturare dalla dispersione.
Una considerazione a parte meriterebbe il posto che il narratore riserva a sé stesso. Il romanzo è in terza persona, ma lo scrittore talvolta fa capolino nella pagina con manzoniana ironia che spesso diventa elegante autoironia. Le parentesi introdotte da frasi del tipo «Se ci si consente di dire la nostra», stabiliscono con il lettore un divertente rapporto di complicità, e fanno intravvedere quanto lo scrittore sa dare anche sul versante saggistico.
Il linguaggio
La lingua che Eugenio Corti usa è funzionale al racconto. La parola è lo strumento, non il fine della comunicazione. Dunque, nessuna evasione di tipo sperimentale, nessun verbalismo narcisistico. Assoluta predominanza del livello denotativo sul livello connotativo. La «poeticità» sta nelle situazioni, nei fatti, nei sentimenti, non nelle parole che non devono rimandare a sé stesse, ma, appunto, alle situazioni, ai fatti, ai sentimenti a cui si riferiscono. Anche i momenti più lirici del romanzo (e ve ne sono molti) non si arrestano alla «bella pagina», ma la attraversano per cogliere la poesia delle cose.
Si vedano, per esempio, i capitoli della morte di Stefano, con quella straordinaria intuizione della madre che, a tremila chilometri di distanza, nella notte, lo sente morire (pp. 320 e ss.); la contesa di Manno con l’usignolo (pp. 535-36); la visita di Michele, in licenza, a casa dei Riva (pp. 134 e ss.) durante la quale scocca l’interessamento per la quindicenne Alma, che la lontananza maturerà in amore (con quel buffo e realistico particolare del gelato che «aveva difficoltà a formarsi», nonostante il prodigarsi dei fratelli minori intorno all’antiquata gelatiera a manovella); la morte del capitano Grandi, portato in barella dai suoi alpini che cessano di cantare solo quando si rendono conto che il capitano ha cessato di vivere (pp. 443 e ss.), e tanti, tanti altri episodi.
Corti, che è anche uomo di teatro, usa molto il dialogo che rende ancor più immediato il realismo della narrazione e, cosa sorprendente, un romanzo di 1.280 pagine risulta «sintetico», nel senso che lo sforzo dell’autore è di condensare, pagina dopo pagina, la vastità della materia, senza incorrere nei tranelli della digressione. Pertanto, eventi capitali come l’uscita di scena di un personaggio (quanti morti, quanti dispersi, nella guerra) vengono spesso liquidati (o, meglio, glorificati) in una sola riga.
Essendo prevalentemente «agito» da briantei, il romanzo abbonda di lombardismi, spesso riprodotti in originale con traduzione italiana in parentesi. Ma quella di Corti non è un’officina linguistica alla Gadda o alla Pasolini: è, semplicemente, realismo. Quella gente parla così, e la scrittura non può far altro che registrare fedelmente. Anche qualche parolaccia (siamo pur sempre tra soldati) viene forzosamente riportata, ma Corti non può fare a meno di esprimere anche con il pudore linguistico la dirittura morale che pervade il romanzo. Ed è stupefacente come l’autore riesca a parlare, da adulto, anche di atrocità, stupri, sevizie (che fanno parte del realismo della storia), rifuggendo anche dal più remoto rischio di morbosità o di allettamento. Il manzoniano «la sventurata rispose» è il modello a cui la saldezza morale di Corti spontaneamente si ispira in questi, peraltro infrequenti, casi.
I personaggi
Ma il pregio decisivo del romanzo di Corti sta nel mettere davanti al lettore non caratteri, ma persone con le quali si ha l’impressione di parlare e di ascoltare. È tale il coinvolgimento, che il lettore non dimenticherà mai non soltanto Ambrogio, Manno o Michele, ma anche Luca, l’alpino generoso e modesto (Corti ha un’autentica venerazione per gli alpini) che, rientrato in patria, avrà il duraturo strazio di apprendere che la sua Giustina è morta di tisi; e l’ispido Igino, e l’abnegato don Mario, e il tenente Laricev – nella vita civile, pittore, che salverà la vita di Michele per un improvviso senso di solidarietà fra artisti –, e la professoressa Quadri Dodini che piange per la cultura quando sente che i tedeschi sono entrati a Parigi, e i personaggi che compaiono col loro nome e cognome: padre Gemelli, Togliatti, Robotti, don Gnocchi, la Jotti… tutti, tutti rimangono nella memoria e nel cuore al termine di un’esperienza non solo di lettura, ma autenticamente esistenziale.
Nell’ultima pagina del romanzo, Corti riporta questi versi da Little Gidding, di Thomas Eliot: «Ecco, ora svaniscono / i volti e i luoghi, con quella parte di noi che, come poteva, li amava, / per rinnovarsi, trasfigurati, in un’altra trama».
Davvero, è così, e la trama è quella della nostra vita. Mi guardo intorno, mi sforzo di ricordare: non vedo nessun altro autore italiano, in questo secolo, in grado di scrivere un romanzo di questa intensità, capace di compiere simili prodigi.
