È da poco uscito per Vita e Pensiero “…E quanto più sapore possibile”. Comunicazione, media e industria culturale. Studi in onore di Fausto Colombo. Curato da Piermarco Aroldi, Giovanna Mascheroni, Francesca Pasquali, Barbara Scifo, raccoglie i contributi con cui allievi, colleghi e compagni di ricerca omaggiano il magistero del professore della Cattolica, protagonista degli studi sulla comunicazione, scomparso prematuramente a inizio 2025. Entrando in dialogo con i temi, gli oggetti e i metodi coltivati dal sociologo, gli autori ne interpretano la preziosa lezione sui tanti fronti da lui brillantemente esplorati (i rapporti tra i media e la società, l’industria culturale che forma l’identità nazionale, i processi di digitalizzazione, le implicazioni per la democrazia). Riportiamo qui il pezzo in cui Paolo Braga prende spunto dalle riflessioni di Colombo sul racconto dello sport.

In alcune sue riflessioni sul vissuto sociale dello sport in Italia e su come la digitalizzazione vi abbia inciso¹, Fausto Colombo auspica che l’evoluzione dei media e i cambiamenti nel modo di spettacolarizzare la pratica sportiva ne preservino il portato valoriale intrinseco. È importante «curare la narrazione dello sport», recuperare la sua «dimensione epica e di avventura». Una lezione significativa al riguardo – nota incidentalmente il sociologo – la si può trovare «nell’industria cinematografica americana».
Intendiamo qui raccogliere lo spunto offerto da questa osservazione di Colombo. Vogliamo schizzare una breve analisi del film sportivo hollywoodiano. Lo faremo riprendendo e approfondendo alcune idee che abbiamo già sviluppato in un nostro saggio² e adotteremo una prospettiva poco frequentata negli studi su questo genere: quella della sceneggiatura³. Ci soffermeremo su due aspetti: la costruzione del personaggio principale e l’azione dell’allenatore.
Dalla parte del meno quotato

La chiave per scrivere un film sportivo è raccontare la storia di un underdog. È una costante di questo genere tratteggiare un protagonista che non gode i favori del pronostico, che parte da condizioni penalizzanti (trascorsi difficili, carenza di mezzi, una carriera apparentemente esaurita e senza acuti, l’essere un novizio nella disciplina). Gli sceneggiatori usano rimarcare questa caratterizzazione con pennellate decise. In Rocky (1976), l’eponimo personaggio (Sylvester Stallone), prima ancora che gli arrivi la sfida del campione dei pesi massimi, è bollato dal suo futuro allenatore come «una scamorza» («tomato» nell’originale), perché il pugile, privo di grinta, si è da sempre di buon grado adattato a barcamenarsi in incontri di scarso livello. Stessa esplicitezza nella telecronaca che in Warrior (2011) così sottolinea la disparità tra i protagonisti e l’imbattibile lottatore russo che detiene il titolo: «Missione impossibile, game over, a casa». Difficile essere più chiari (crudi e brillanti) del general manager Billy Beane (Brad Pitt) che, in avvio di stagione, all’inizio di Moneyball (2011), spiega ai suoi collaboratori dove posizionare, partendo dall’alto, il loro team di baseball: «Ci sono squadre ricche, e ci sono squadre povere. Poi ci sono venti metri di merda. E poi ci siamo noi…».
L’underdog è un’opzione affidabile. In primo luogo, dispone il pubblico all’empatia⁴. Tutti, infatti, siamo stati qualche volta in condizioni di inferiorità. In secondo luogo, apre allo sceneggiatore lo spazio per sviluppare una parabola di spiccata trasformazione del personaggio (da perdente a vincente, dalla sfiducia alla determinazione). L’underdog fa subito presagire tale arco e pregustarlo agli spettatori, che lo sanno ricorrente nelle pellicole sportive. Inoltre, la condizione di sfavorito è usata come occasione per raccontare sistemi creativi di allenamento o di competizione. I quali, mentre divertono, offrono al pubblico un’ottica inedita e stimolante, per ricordare che si può sempre fare di necessità virtù. Cioè, per riconfigurare certezze troppo rigide in materia di vantaggi e svantaggi⁵. Si pensi a Rocky che si allena colpendo dei quarti di bue in una cella frigorifera. In Moneyball, Billy Beane sopperisce alla mancanza di soldi usando la statistica per scegliere quali giocatori meno costosi, se schierati nel modo giusto, possano formare una compagine da primato. In Per vincere domani – the Karate Kid (1984) gli eccentrici insegnamenti zen di Miyagi pagheranno, rendendo possibile il colpo decisivo di Daniel (Ralph Macchio) nel combattimento finale.
D’altra parte, l’aspetto saliente dell’azione dell’underdog è l’abnegazione, l’applicazione. Senza di ciò, il gap con l’overdog resta incolmabile. Questa insistenza, questo spendersi senza risparmio, fa dell’underdog una proiezione delle attese di giustizia del pubblico⁶. Può essere lo sforzo prodotto in allenamento. Come le interminabili ripetute sul ghiaccio, fino a notte fonda, cui in Miracle (2004) coach Brooks (Kurt Russell) costringe i suoi giocatori di hockey nel dopo partita. Può essere anche lo sforzo interiore. Come quello di Rocky, che si dispone alla sofferenza di un incontro in cui dovrà soprattutto incassare, «farsi massacrare». Oppure, come, in Tornare a vincere (2020), coach Cunningham (Ben Affleck), che per allenare dei ragazzi deve affrontare i suoi demoni (l’alcolismo, la morte di un figlio). Al cuore, il genere sportivo celebra la convinzione che lo sforzo autentico non resta vano. L’ordine superiore che regge le cose umane premierà il merito.
L’allenatore come un padre
L’altro elemento distintivo dei film sullo sport è la relazione allenatore-atleta/i. In termini drammaturgici, è una relazione tra mentore-allievo/i⁷, la quale si riempie di contenuti affettivi delineandosi come surrogato di una relazione tra padre e figlio/i. Alla resa di questa componente i titoli sportivi di maggior successo devono senz’altro una parte della loro fortuna. Perché sono riusciti, con la scrittura, e anche con il casting, a mescolarvi note di schiettezza, generosità, severità e ruvido consiglio. Note di trasporto pieno di orgoglio e di fervente incoraggiamento.
In certi casi la valenza paterna è latente e lascia spazio ad altre connotazioni.
Si pensi a Rocky e al suo anziano allenatore Mickey (Burgess Meredith), il volto da vecchio marinaio, la schiena incurvata e il carattere inacidito dagli anni. Quello che nasce tra loro è il sodalizio tra due nessuno di una borgata di Filadelfia. Due lasciati indietro che si aggrappano l’uno all’altro per risalire la china adesso che, inattesa, si è aperta un’impervia scorciatoia (Rocky ha paura del grande incontro col campione del mondo, Mickey di andarsene avendo mancato l’unica, vera, tardiva occasione di una vita).
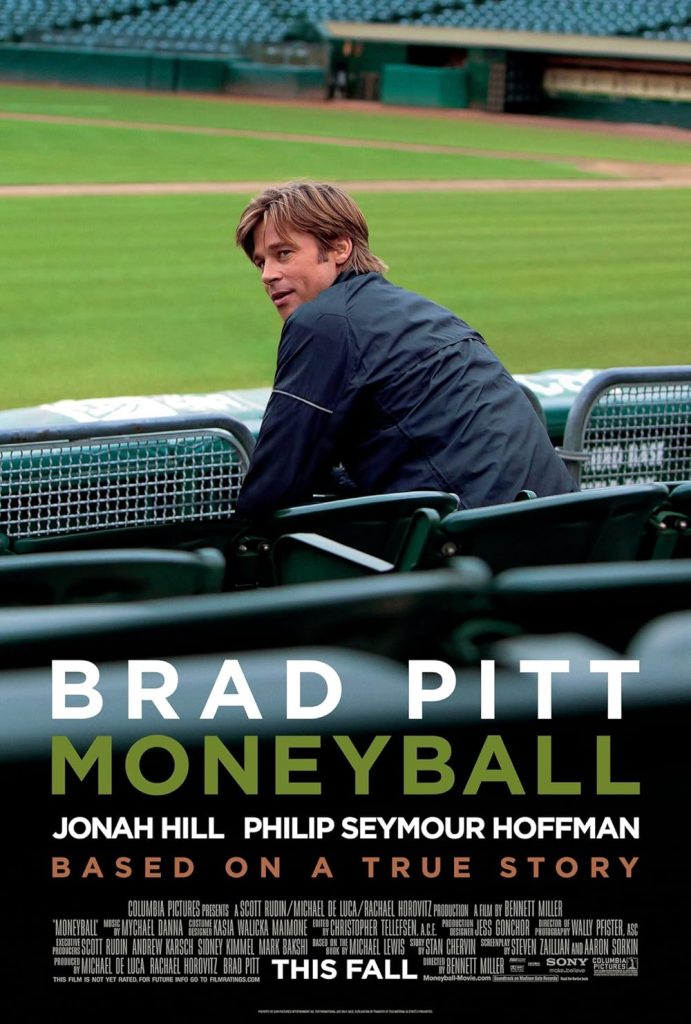
In certi casi, la relazione tra la squadra e chi la guida è addirittura in controtendenza: deprivata di coinvolgimento, schiacciata sul rapporto meramente professionale. Così è in Moneyball, dove Billy Beane, quando deve cedere un giocatore, lo comunica laconicamente all’interessato, senza preamboli né edulcorazioni, perché tutti sanno che è così che funziona nell’ambiente. Una sfaccettatura, questa, del rapporto complicato che il protagonista del film ha con il suo sport.
Tuttavia, nella più parte dei film, la connotazione genitoriale, sia pure in senso lato, è spiccata: l’allenatore è figura adulta responsabile non solo del far giocare, ma anche dell’educare. Non di rado un professore di high school (si pensi a Coach Carter, 2005), che con la sua presenza sollecita colma lacune familiari dei suoi ragazzi.
Inoltre, ci sono film in cui il rapporto con l’atleta è addirittura integralmente costruito sul modello di una relazione tra un padre e un figlio. Com’è in Million Dollar Baby (2004), in cui Maggie (Hilary Swank) occupa nel cuore di Frank (Clint Eastwood) il posto lasciato vuoto dalla figlia con cui l’uomo ha interrotto i rapporti, mentre lui diventa per l’atleta il genitore che lei ha perduto.
Il discorso dell’allenatore

Un protagonista dato per perdente, o comunque messo a mal partito. Una relazione con una figura esperta che incoraggia. Il dramma interiore della motivazione per provarci. Tutto questo nei film sportivi trova la sua celebrazione in una scena topica: il monologo con cui l’allenatore trasmette all’atleta grinta, forza d’animo, speranza. È il discorso da spogliatoio, il locker room o pregame speech. Un passaggio della trama potente. Alcune formule retoriche ricorrenti vi sono di volta in volta declinate con l’aggiunta (almeno questo è l’impegno degli sceneggiatori) di sfumature innovative. Cioè, di punch line usate per la prima volta, o di metafore inedite, che contrassegnino la prova oratoria, per il resto rispondente a canoni consolidati, in modo da guadagnarle (complice l’interpretazione attoriale e la colonna sonora) una sua originalità. Così che lo speech possa aggiungere qualcosa al repertorio di suggestioni motivazionali che il genere sportivo, con i suoi discorsi, ha costruito nei decenni.
I monologhi più riusciti diventano il biglietto da visita della pellicola che li contiene. La contrassegnano nel ricordo degli spettatori. Acquistano vita propria. Esempi di arte oratoria, di parola suadente, di leadership maschia ed eloquente fruibili su YouTube. Speech ripresi anche in contesti lontani dal cinema e dallo sport. Per esempio, sui siti o nelle lezioni di coaching aziendale: usati per spiegare l’atteggiamento “giusto” in vista dell’obiettivo di business. Per spingere a collaborare con i colleghi come fossero compagni di squadra. Interventi che a volte si offrono anche all’esercizio dell’analisi retorica classica, interessata a censire quali figure retoriche siano alla base della loro forza comunicativa.
Ma non è, quest’ultimo, l’approccio migliore per capire da dove venga tale forza. Che si comprende meglio, invece, adottando la lente narrativa della tecnica di sceneggiatura. Cioè, riconoscendo che i discorsi da spogliatoio cavalcano l’onda di sentimenti sollevata dalla drammaturgia che abbiamo indicato (l’underdog, il sodalizio con il mentore, le ferite nella sua backstory…). Inoltre, riconoscendo che questi speech (come, del resto, in generale, tutti i movie speech, inclusi quelli non sportivi) sono essi stessi una storia. Quantomeno in filigrana, hanno forma narrativa. Le parole dell’allenatore suggeriscono l’idea di una certa vicenda – uno script, un frame cognitivo – che può essere più o meno esplicito, più o meno articolato nei suoi passaggi. E che, alla radice, è sempre la storia di un viaggio alla ricerca della motivazione. Viaggio in cui l’oratore accompagna i suoi uomini. Inoltrandosi lui in un percorso di scoperta di quello che conta davvero. Della chiave di volta che libera lo spirito e la speranza. Il che, nell’andamento più classico, si realizza a discorso ben avviato. In un suo momento definibile “aurorale”: quando l’allenatore mostra finalmente di aver penetrato il segreto della motivazione, cioè di quello che conta davvero per vincere. Quando, dunque, è il primo a farsi pervadere da quell’energia. La fase successiva e conclusiva dello sforzo oratorio sarà perciò dedicata a contagiare di passione chi ascolta.
Quattro moduli retorici per motivare
Accennavamo sopra al ventaglio limitato di moduli retorici a cui i pregame speech in definitiva sono riconducibili. Il viaggio della motivazione può essere proposto lungo alcuni, pochi, itinerari narrativi. Sono quattro soluzioni, quattro grandi tipologie di discorso. Prove ulteriori del radicamento del genere sportivo nella cultura americana, visto che queste categorie archetipiche di appello motivante si ritrovano in tutto il cinema statunitense. Perché del carattere di quel Paese, di lati della sua mentalità, sono il portato. Anche se poi, toccando leve psicologiche basilari, i tipi di speech hanno una presa universale e trovano corrispettivi in tutte le culture.
Per il suo alimentarsi a un istinto atavico di reazione e aggressione, per il suo ispirarsi a un ideale squisitamente agonistico – competitivo, di confronto a muso duro con l’avversario –, per il risalto che vi ha la caratterizzazione da underdog, c’è un tipo di discorso sportivo che ha una canonicità speciale. È lo speech che possiamo definire “del lottatore”, perché questo è il ruolo assuntovi dall’allenatore, e da lui proiettato sui suoi giocatori. Il monologo propone loro di calarsi in una storia eroica di accettazione della sofferenza necessaria a sconfiggere una compagine che appare soverchiante. È la tipologia di appello che punta di più sulla leva psicologica dell’empowerment: il sentirsi in grado di fare risultato, di “offendere”, di esporre la fragilità del più forte che si va ad affrontare.
Lo speech si sviluppa abitualmente così. Il coach dà inizialmente voce alla paura dei suoi (non siamo messi bene, gli altri sono una corazzata…). Poi prefigura la durezza della prova (dipinge, diciamo, la traversata nel deserto). E scopre (è il momento aurorale) nella decisione di resistere e di spendersi nonostante tutto (di non scappare, di bere fino in fondo il calice amaro) il viatico all’impresa (perché nessun’arma è superiore alla volontà, perché il destino premia il sacrificio, perché l’avversario comincerà a cedere…). A questo punto, il coach alimenta il flusso della combattività affiorante dalla breccia aperta nel cuore degli atleti (la cui coesione, il cui essere tutti per uno e uno per tutti, renderà la squadra un corpo contundente assai pericoloso per l’overdog). Se l’esordio del discorso era sulla paura, le note conclusive trasmettono voglia di battersi, di mettere al tappeto chi doveva dominare. Come si vede, risalta un’impronta guerresca. Un gusto per la prodezza marziale, riconducibile alle origini storiche dei discorsi da lottatore: che sono nel football americano negli anni dell’imperialismo Usa e della Guerra fredda. In particolare, nella retorica di alcuni celebrati allenatori – e richiesti public speaker nella loro epoca – come Knute Rockne (alla guida dei Notre Dame Fighting Irish tra il 1918 e il 1930) e Vince Lombardi (il quale si era formato a West Point, prima di entrare nella leggenda con i Green Bay Packers, allenati dal 1959 al 1967).
L’esempio più famoso di discorso da lottatore è quello di Tony D’Amato agli Sharks, recitato da Al Pacino in stato di grazia, prima della partita clou di Ogni maledetta domenica (1999). Allenatore di football in declino, ritenuto dai metodi superati, umanamente perso, D’Amato esordisce riconoscendo di non saper che dire prima di quella gara che, per tutti, lì, è la più importante della carriera. Si trovano «all’inferno», ma lui ammette di non poter aiutare i suoi uomini. Cosa che invece inizia a fare, andando alla ricerca della motivazione lungo un viaggio autobiografico in cui l’uomo arriva a confessare tutti i propri errori. Fino al punto più basso, la constatazione che quello che la vita fa è «togliere», deprivare. Ecco allora il momento aurorale: il pensiero che nella vita, come nel football, anche pochi centimetri possono fare la differenza. Che, se un centimetro può essere misura di arretramento, può esserlo anche di avanzamento. Una misura ridotta e per questo prendibile, a patto di dare tutto per quel piccolo spazio, e per ogni altro piccolo spazio successivo. Come, ne è convinto, la sua squadra è abituata a fare. Di qui, il crescendo conclusivo, dove quella convinzione tracima in un inno al sacrificio per i compagni, e alla fiducia reciproca nel momento più brutale dello scontro. Il momento che, quando Pacino ha finito di parlare, gli Sharks nello spogliatoio sembrano non veder l’ora di affrontare.
Un secondo tipo di discorso da spogliatoio ha respiro più “umanistico”. Meno imperniato sul conflitto con il top dog, punta piuttosto sulla nobiltà d’animo, sul fervore delle coscienze. Qui il coach assume il ruolo di un “ispiratore”. Fa sua una postura “omiletica”, come si appropriasse dei compiti di predicazione del cappellano della squadra. L’oratore declina ora un plot di rinascita: dall’appannamento dei valori (la squadra ha smarrito la sua identità perché sotto nel punteggio, o perché ci sono screzi), attraverso un esame di coscienza (un viaggio interiore) per recuperare il senso dello stare insieme, fino a un cammino comune all’insegna di un’umanità migliore, per la quale anche lo sport può dare un contributo. Dunque, una traiettoria che muove dal presente; vira al passato per trovare materia con cui risvegliare il senso morale; termina su un futuro luminoso per tutti. Lo schema è quello della “geremiade”, la forma di predicazione di ascendenza biblica ampiamente usata nel mondo protestante americano, mutuata via via anche in contesti extra-religiosi e civili (tra gli altri, da Martin Luther King, e dal presidente Johnson). Nel discorso da ispiratore è più frequente il rilievo che quello che si fa lo si fa per gli altri (per dare felicità e coraggio ai concittadini; oppure, per far sentire ancora parte del gruppo, dedicandogli la partita, un compagno di squadra che ha smesso di giocare a causa di un infortunio).
Il personaggio di Denzel Washington in Il sapore della vittoria (2000) assume chiaramente una postura da ispiratore. Lo fa prendendo di petto la questione del cattivo sangue che corre tra bianchi e neri nel suo team liceale di football. Avendoli portati ad allenarsi nei pressi del cimitero di guerra dove riposano i caduti della battaglia di Gettysburg, in un inatteso, accorato speech, coach Boone usa la testimonianza rappresentata da quelle vittime dell’odio tra fratelli (la lezione del passato) per mettere in guardia i ragazzi. Che potrebbero patire la stessa distruzione. Oppure, lasciarla per sempre alle spalle, imparando a rispettarsi (l’enunciazione di questo valore, del rispetto, è il punto di svolta). Così da riuscire a giocare (ma, è evidente, anche, più in generale, a vivere) da uomini (lo sguardo su un auspicabile futuro). Altrettanto intenzionato a spingere la squadra a guardarsi dentro è il discorso di un altro film, Friday Night Lights (2004). Qui l’ispiratore – coach Gaines (Billy Bob Thornton) –, quando i suoi, durante la finale, sono sotto nel punteggio, ricorda le tante volte in cui ha raccomandato loro «perfezione» (il passato del gruppo). Ma Gaines svela adesso un significato più profondo del termine, che non riguarda il football o il punteggio. Riguarda invece, spiega, il dedicare quello che si fa, senza risparmio, con gioia, agli altri. In particolare, al compagno Boobie Miles, il più promettente fra loro, che, con un ginocchio leso, non potrà più giocare. Così si sentiranno rigenerati. Come dice Gaines: avranno il cuore «ricolmo».
Il terzo tipo di discorso risente di meno dell’influenza culturale statunitense. Nasce da un impeto d’ira ritrovabile a tutte le latitudini. Attinge a moti istintivi e universali di condanna contro chi, in errore, persevera, pago e al riparo di una posizione di privilegio. Il coach si cala qui nel ruolo, diciamo, di un “fustigatore”. Si produce, cioè, in un’invettiva e sfrutta lo schema narrativo connaturato a questo genere oratorio. Quello di un testimone della verità, il quale si decide a rompere il perdurante, succube, generale silenzio sulle malefatte di chi, impunito, ipocrita, si sente tranquillo, protetto dalle apparenze, da un prestigio immeritato. Nella fattispecie sportiva, il bersaglio dello sfogo sono atleti che non si impegnano, adagiati sugli allori. L’underdog ha smesso di pensarsi come tale. I giocatori indossano una divisa che ne fa dei beniamini, magari ricchi e viziati, ma il loro comportamento è indegno di quei colori. Così, per esempio, in Blue Chips – Basta vincere (1994) coach Bell (Nick Nolte) minaccia la sua squadra di basket senza mordente che li farà scendere in campo nudi.
In generale, un’invettiva si articola in una serie di passaggi canonici e sfocia in una predizione di rovina per il destinatario, di poderoso ritorno della giustizia. I film sportivi ne danno versioni meno articolate. Concentrate soprattutto nella fase della denigratio. Sanguigne e offensive, sono (come è del resto verosimile nel contesto umorale di uno spogliatoio) delle sfuriate. A volte, però, lo sceneggiatore riesce a dotarle di una creatività sarcastica, di un’arguzia offensiva che le rende pregevoli, per quanto Cicerone resti un’altra cosa. Per esempio, quando, in Moneyball, Billy Beane sorprende i suoi a spassarsela nonostante una sconfitta. Avendo imposto brutalmente il silenzio, li lascia sospesi per alcuni secondi, per precipitarli subito dopo, con una sola, laconica frase, nella mortificazione: «Questo è il suono della sconfitta…».
Al contrario del rant, cioè della “strigliata”, l’ultimo tipo di discorso sportivo è molto americano. È, infatti, il portato di una cultura che da sempre celebra la capacità di vendere, di esaltare un prodotto, di presentare efficacemente un’idea di business a dei finanziatori (a Hollywood, l’idea di un film a un produttore). Insomma, di fare quello che in gergo si chiama pitch. Cosa che in un film sportivo impegna l’allenatore quando questi deve introdurre alla squadra il suo modulo tecnico e persuadere i giocatori a seguirlo nella sua visione. Dunque, calandosi nel ruolo oratorio di “un pioniere” che – questo il plot – invita alla sequela. A lasciare il noto (non esaltante, ma rassicurante) per il nuovo (una promessa di eccellenza) imparando a guardare la realtà con occhi diversi. Immaginandosi protagonisti di una storia straordinaria, di cui è condizione il metter da parte le pur comprensibili ragioni per non rischiare.
Annuncio; concessio; highlights di un futuro in cui finalmente ciascuno esprime le sue capacità migliori. Queste le fasi caratteristiche di uno speech da pioniere, che si ritrova in pochi, ma gustosi esempi. La loro esiguità si deve a una difficoltà espositiva: come rendere accettabile e addirittura accattivante per lo spettatore uno speech su materia tecnica (moduli tattici, posizioni in campo ecc.)? La soluzione è incentrare lo speech su una metafora esplicativa e suggestiva. Così, nella serie Winning Time (2022-2023, episodio 4), secondo il nuovo allenatore dei Lakers, votarsi nel basket al gioco verticale è come passare dalla musica classica al jazz. Cioè, a un disordine organizzato. Come il fluire di uno stormo di uccelli, o delle farfalle: un apparente caos che è in realtà «la sinfonia di madre natura». In Moneyball, a calarsi nel ruolo di pioniere è invece il consulente Peter Brand. Per convincere il protagonista interpretato da Pitt che schierati e combinati con la giusta logica anche atleti svalutati possono creare un insieme vincente, Brand usa l’immagine pregna di riscatto dell’«Isola dei giocattoli difettosi».
D’altra parte, il discorso sportivo da pioniere ha anche una declinazione meno “specialistica”. Più psicologica ed esistenziale. È quando all’atleta è proposta una visione alternativa di sé, indirizzandolo alla scoperta di un potenziale che non immaginava di avere. Che lo completerebbe, trasformandolo nel suo true self, nella versione migliore e più vera di sé. Così è lo speech che in Air – La storia del grande salto (2023) il talent scout della Nike Sonny Vaccaro (Matt Damon) rivolge al giovane Michael Jordan («Tu sei Michael Jordan e la tua storia ci farà venire voglia di volare!»).
Conclusioni: il coraggio di motivare e di formare
Per certi versi, il genere sportivo punta sulla voglia del pubblico di sognare. Di lasciar spazio a fantasie positive che nella vita quotidiana sono inibite dal realismo. I suoi plot di trasformazione da brutto anatroccolo (su cui non si scommetterebbe) a cigno (campione) sono avvicinabili al modello della fiaba. Sono Cinderella stories che inducono a sospendere il pessimismo della ragione, in nome del piacere di immaginarsi speciali, a dispetto delle apparenze.
Per altri versi, i film sportivi toccano dimensioni caratteriali profonde. Offrono un ventaglio essenziale di modalità interiori primarie, da adottare per reagire alle difficoltà. Oltre che alla fiaba, vanno dunque accostati a racconti ancestrali: sì Cenerentola, ma anche Davide contro Golia.
È soprattutto grazie alla relazione archetipica tra allenatore e atleta/mentore ed eroe che la retorica narrativa degli sport movie guadagna questa credibilità psicologica. È il rapporto tra i due ruoli, quando scritto bene, che riesce ad attualizzare la forza affabulatoria e pedagogica del mito. Mantenendo viva la percezione di alcuni princìpi semplici, ma culturalmente necessari (il valore dell’impegno, della collaborazione, della trasmissione dell’esperienza, la riscoperta del senso dell’agire comune ecc.).
Se il racconto dello sport, come suggerisce Fausto Colombo, può guardare alla lezione americana, è soprattutto, crediamo, nel far proprio questo gusto schietto per la motivazione e l’elevazione del pubblico.

Bibliografia
Braga P., Come parlano gli eroi. I grandi discorsi al cinema, in politica, nello sport, Guerini e Associati, Milano 2024.
Colombo F., “Lo sport sul palcoscenico sociale. Metamorfosi della narrazione sportiva”, Note di pastorale giovanile, n. 4 (2021), pp. 16-20.
Gladwell M., David & Goliath. Underdogs, Misfits, and the Art of Battling Giants, Little, Brown and Company, New York 2013.
McKee R., Character: the Art of Role and Cast Design for Page, Stage, and Screen, Hachette, New York 2021.
Tirino M., Film e sport. Dinamiche di una relazione mediologica e socio-culturale, in Sport e comunicazione nell’era digitale, a cura di L. Bifulco et al., FrancoAngeli, Milano 2023.
Truby J., Anatomy of Genres. How Story Forms explain the Way the World Works, Picador, New York 2022.
Vandello J.A. et al., “The Appeal of the Underdog”, Personality and Social Psychology Bulletin, n. 12 (2007), pp. 1603-1616.
Vogler C., The Writer’s Journey: Mythic Structure for Writers, Michael Wiese production, Studio City 1992.
1 F. Colombo, “Lo sport sul palcoscenico sociale. Metamorfosi della narrazione sportiva”, Note di pastorale giovanile, n. 4 (2021), pp. 16-20.
² Cfr P. Braga, Come parlano gli eroi. I grandi discorsi al cinema, in politica, nello sport, Guerini e Associati, Milano 2024.
³ Anche se la letteratura in questo àmbito è scarsa. Del film sportivo si occupa per qualche pagina solo John Truby, nella seconda parte del capitolo 2 di The Anatomy of Genres. How Story Forms explain the Way the World Works, Picador, New York 2022. Non seguiremo, però, qui la sua analisi, orientata a evidenziare la parentela con il genere action. Per una panoramica sugli studi dedicati al genere sportivo da altre prospettive, rimandiamo invece a M. Tirino, Film e sport. Dinamiche di una relazione mediologica e socio-culturale, in Sport e comunicazione nell’era digitale, a cura di L. Bifulco et al., FrancoAngeli, Milano 2023, pp. 33-46.
⁴ Robert McKee, il più autorevole script consultant e docente di sceneggiatura, sottolinea nei suoi libri la carica empatica che l’underdog ha non solo nel genere sportivo. Si vedano, per esempio, le considerazioni sul «balance of power» in Idem, Character: the Art of Role and Cast Design for Page, Stage, and Screen, Hachette, New York 2021, capitolo 16.
⁵ È l’argomento di uno stimolante saggio di Malcolm Gladwell sugli underdog fuori dal cinema, nella realtà: David & Goliath. Underdogs, Misfits, and the Art of Battling Giants, Little, Brown and Company, New York 2013.
⁶ Anche ricerche psicologiche si soffermano sul nesso tra underdog e senso di giustizia. Cfr. J.A. Vandello et al., “The Appeal of the Underdog”, Personality and Social Psychology Bulletin, n. 12 (2007), pp. 1603-1616.
⁷ Sul ruolo del mentore in una sceneggiatura il rimando obbligato è al manuale di scrittura che più di tutti gli ha dato risalto: C. Vogler, The Writer’s Journey: Mythic Structure for Writers, Michael Wiese production, Studio City 1992.